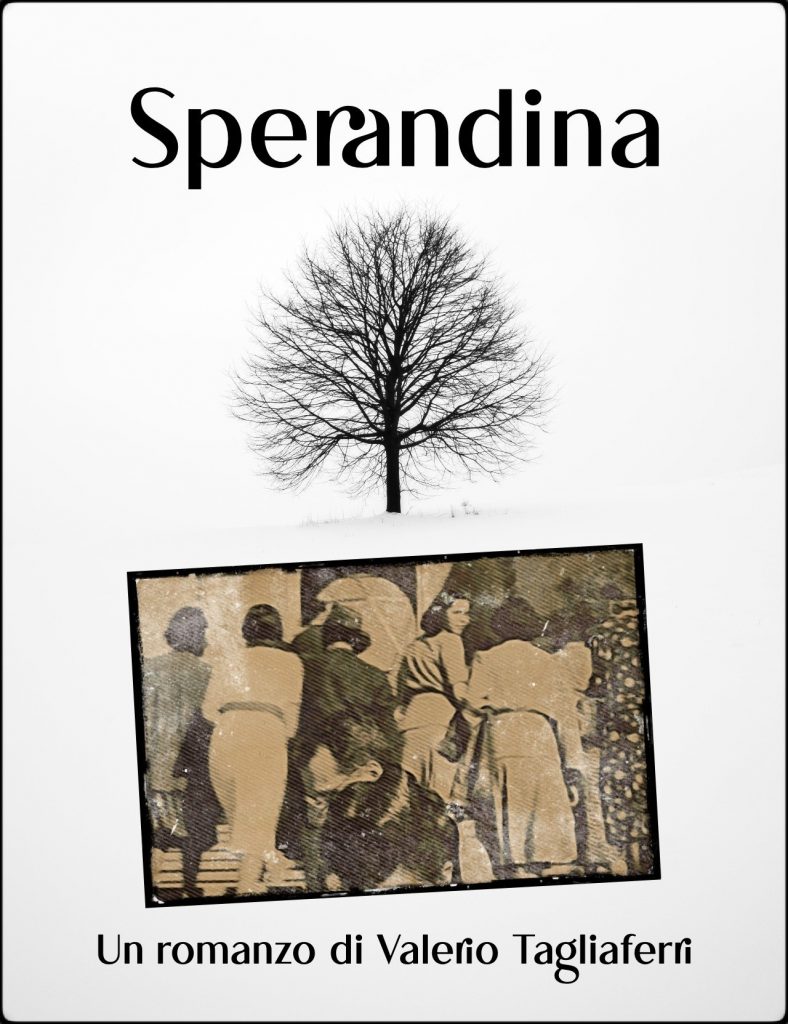(UK,1966)
Questo è un film che, ad ogni sua visione, ci costringe a riflettere sulla natura umana e sul potere della conoscenza. Tratta dall’omonimo e bellissimo romanzo di Ray Bradbury, questa pellicola rappresenta un unicum nella carriera di François Truffaut, il maestro della “Nouvelle Vague”, che con questo lavoro si confronta per la prima volta con la fantascienza, con la lingua inglese e con il colore.
In un futuro distopico, i libri sono banditi e i pompieri, invece di spegnere incendi, li appiccano per distruggere ogni traccia di sapere e di pensiero critico. Il protagonista, Guy Montag, interpretato da un magnetico Oskar Werner, è un pompiere devoto al suo lavoro, finché un incontro fortuito con la vivace e curiosa Clarisse, portata sullo schermo da una straordinaria Julie Christie, lo spinge a mettere in dubbio tutto ciò in cui crede.
Truffaut ci regala un’opera visivamente ipnotica, dove il colore diventa protagonista tanto quanto i personaggi. L’uso del rosso, simbolo di distruzione ma anche di passione, domina la scena, sottolineando la tensione tra un mondo che brucia la cultura e la nascente consapevolezza di Montag. La scenografia è minimalista, quasi alienante, a sottolineare la sterilità emotiva di una società che ha sacrificato l’anima sull’altare della conformità.
Fondamentale è anche la colonna sonora firmata da Bernard Herrmann, musicista fra i preferiti del maestro Alfred Hitchcock, che Truffaut cita e omaggia in quasi ogni scena. La loro personale amicizia, nata da un’intervista che il cineasta francese gli fece per poi scrivere lo splendido “Il cinema secondo Hitchcock”, è parte integrante della storia del cinema.
Julie Christie offre una performance memorabile, incarnando sia Clarisse, l’elemento di disturbo che accende la scintilla del dubbio in Montag, sia Linda, la moglie apatica e sottomessa al sistema. Questo doppio ruolo non solo dimostra la versatilità dell’attrice, ma rafforza il contrasto tra la vita che Montag desidera e quella a cui è stato condannato.
La scelta di Truffaut di adattare “Fahrenheit 451” di Bradbury può apparire paradossale per un regista che ha costruito la sua carriera su storie intime e umane. Tuttavia, è proprio questa distanza dall’opera originale che permette a Truffaut di esplorare nuovi territori cinematografici, pur mantenendo la sua sensibilità poetica. Non è un film di fantascienza nel senso convenzionale del termine, ma piuttosto una riflessione sull’alienazione, sull’individualismo e sulla resistenza all’omologazione.
Ma sopratutto “Fahrenheit 451” è un inno immortale alla lettura e all’amore per i libri, libri che per lo stesso Truffaut furono, durante la sua difficile adolescenza, l’unico vero punto fermo e faro illuminante. Le semplificazioni narrative rispetto al romanzo di Bradbury non sono mancanze, ma scelte consapevoli che orientano il film verso una dimensione più simbolica che didascalica.
Se il ritmo del film può risultare lento per alcuni, questa lentezza è funzionale alla costruzione di un’atmosfera di crescente oppressione e disagio. Truffaut non cerca di catturare lo spettatore con effetti speciali o colpi di scena, ma lo invita a immergersi in un mondo in cui l’assenza di cultura diventa la vera minaccia, più inquietante di qualsiasi mostro fantascientifico.
In definitiva, “Fahrenheit 451” non è solo un adattamento di un romanzo celebre, ma un’opera d’arte a sé stante, che porta l’impronta inconfondibile del grande cineasta francese. Un film che sfida il pubblico a interrogarsi sul valore della cultura e della libertà in un’epoca di crescente conformismo. Truffaut dimostra che la fantascienza, nelle mani giuste, può essere uno strumento potente per esplorare le profondità dell’animo umano e per denunciare le derive della società contemporanea.
“Fahrenheit 451” è un film che va visto, non solo per la sua bellezza visiva o per le interpretazioni dei suoi attori, ma perché ci ricorda quanto sia importante difendere il diritto di pensare, di leggere, di sapere. Truffaut ci consegna un monito potente, un invito a non spegnere mai quella scintilla di curiosità e ribellione che ci rende veramente umani, un monito mai obsoleto e oggi, drammaticamente, tanto attuale.
Ascolta gratuitamente il podcast di questa e di altre recensioni su Spotify e YouTube.